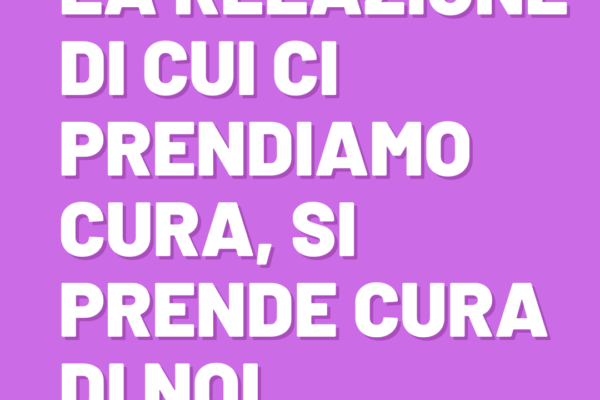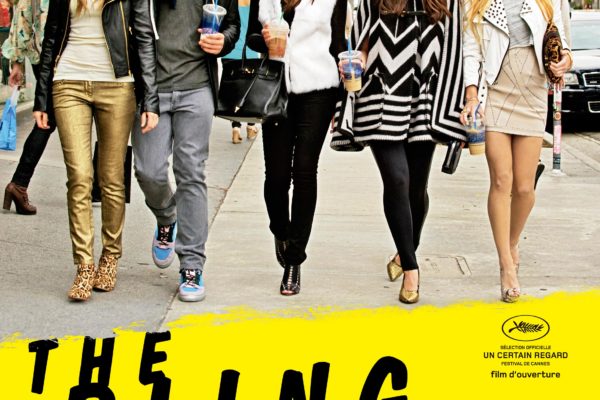Bang, Boom, Gulp! Un Fumetto per capirsi. L'iniziativa lombarda degli psicologi.
 Tutti vogliono parlare con i ragazzi ma raramente si addentrano nei loro linguaggi, benchè parlare un linguaggio comune sia fondamentale per non fraintendersi. E allora? Proviamoci con un fumetto. Da parte mia, ogni volta che si utilizza il fumetto, da amante del genere, non posso che sostenere l’iniziativa. Allarghiamo lo sguardo. In terapia, in consulenza, per la strada o in uno sportello di ascolto la comunicazione è verbale e non. Lasciamo da parte la non verbale, che pure tanto dice, ma la verbale si nutre del linguaggio di chi abbiamo di fronte, serve per comunicare, non ostentare, comunicare non giudicare, comunicare non etichettare. Quindi? Quindi avrà bisogno di parlare tante lingue. Nel colloquio in terapia e non solo, confluisce la teoria e lo stile, la tecnica e il personale modo di usarla ma anche, e a volte soprattutto, il mondo in cui si vive, romanzi, film, immaginario, proverbi e arti in genere. Perché non il fumetto, nona arte spesso maltratatta che da oltre un secolo esiste e spesso se ne sta in disparte, roba da nerd, lasciata in un angolo come fosse poco utile.
Tutti vogliono parlare con i ragazzi ma raramente si addentrano nei loro linguaggi, benchè parlare un linguaggio comune sia fondamentale per non fraintendersi. E allora? Proviamoci con un fumetto. Da parte mia, ogni volta che si utilizza il fumetto, da amante del genere, non posso che sostenere l’iniziativa. Allarghiamo lo sguardo. In terapia, in consulenza, per la strada o in uno sportello di ascolto la comunicazione è verbale e non. Lasciamo da parte la non verbale, che pure tanto dice, ma la verbale si nutre del linguaggio di chi abbiamo di fronte, serve per comunicare, non ostentare, comunicare non giudicare, comunicare non etichettare. Quindi? Quindi avrà bisogno di parlare tante lingue. Nel colloquio in terapia e non solo, confluisce la teoria e lo stile, la tecnica e il personale modo di usarla ma anche, e a volte soprattutto, il mondo in cui si vive, romanzi, film, immaginario, proverbi e arti in genere. Perché non il fumetto, nona arte spesso maltratatta che da oltre un secolo esiste e spesso se ne sta in disparte, roba da nerd, lasciata in un angolo come fosse poco utile.
Bene, abbiamo sbagliato. Il fumetto cresce ogni anno e comunica eccome, racconta fatti accaduti, entra nel merito di avvenimenti e storie. E lo fa sempre meglio. Certo in passato è stato usato a scopo divulgativo per inneggiare a questo o quello come per indottrionare, basta ricordarsi il fumetto nella propaganda fascista, ma con il tempo ha acquisito personalità e agilità di linguaggi. Pensiamo a Maus di Spiegelman, che racconta l’olocausto ebreo utilizzando topi, gatti e maiali ma non perdendo la sofferenza del racconto o ai fumetti che documentano storie accadute, reali,che trattano anche argomenti spinosi come la Palestina di Joe Sacco, la Corea del Nord di Guy Delisle e molti altri. Il fumetto, oggi chiamato più elegantemente “graphic novel”, ma io non sono elegante, capita sempre più spesso, si faccia portavoce di emozioni e stati d’animo, crea metafore da vivere, situazioni simili a quelle della vita comune o anche estremamente diverse, tanto da potercisi riconoscere.
Come nelle favole, il significato si veste di immagini e riesce ad entrare in contatto con il lettore, a farlo immedesimare in diversi personaggi,dandogli un linguaggio nuovo e nuovi occhi utili per un cambio di prospettiva sulla propria vita o anche solo per un momento di libertà dal quotidiano, di sogno e altro. La storia del fumetto non è stata facile, spesso visto come seduttivo e pericoloso, censurato e banalizzato lentamente ha ritrovato il suo genuino modo di essere, di parlare e di rappresentare il mondo.  Se anche nel nostro paese è stato osteggiato negli anni cinquanta come fenomeno che rendeva il lettore meno capace di leggere ( Imbasciati-Castelli; Psicologia del fumetto; Firenze Guaraldi, 1975), come problema per l’ordine sociale e portatore di patologie, oggi è proprio chi di società e comunicazione si occupa a utilizzare questo strumento per far sentire forte e chiari messaggi diversi. Perché il fumetto parla due lingue, quella diretta delle immagini, della storia che racconta, dei personaggi che ne compongono la trama e una indiretta, che utilizza i dialoghi, i simboli, le immagini per dare un messaggio, per metacomunicare in maniera più o meno velatamente rispetto ad un tema o ad un messaggio che si vuole condividere. Per decenni i personaggi di Charles M. Shultz hanno comunicato e ancora lo fanno, con le loro immagini semplici e i tratti precisi, i pensieri di un mondo di bambini capace di arrivare agli adulti, la tenerezza e la meraviglia ma anche emozioni di solitudine e fragilità, commuovendo generazioni e arrivando a far parlare di sè come commedia umana da un nome come Umberto Eco.
Se anche nel nostro paese è stato osteggiato negli anni cinquanta come fenomeno che rendeva il lettore meno capace di leggere ( Imbasciati-Castelli; Psicologia del fumetto; Firenze Guaraldi, 1975), come problema per l’ordine sociale e portatore di patologie, oggi è proprio chi di società e comunicazione si occupa a utilizzare questo strumento per far sentire forte e chiari messaggi diversi. Perché il fumetto parla due lingue, quella diretta delle immagini, della storia che racconta, dei personaggi che ne compongono la trama e una indiretta, che utilizza i dialoghi, i simboli, le immagini per dare un messaggio, per metacomunicare in maniera più o meno velatamente rispetto ad un tema o ad un messaggio che si vuole condividere. Per decenni i personaggi di Charles M. Shultz hanno comunicato e ancora lo fanno, con le loro immagini semplici e i tratti precisi, i pensieri di un mondo di bambini capace di arrivare agli adulti, la tenerezza e la meraviglia ma anche emozioni di solitudine e fragilità, commuovendo generazioni e arrivando a far parlare di sè come commedia umana da un nome come Umberto Eco.
Già negli anni ’90, si utilizzò il tratto di Guido Silvestri per parlare di AIDS con Lupo Alberto, scatenando non poche polemiche in un paese dove è difficile parlare di sesso, tabù e profilattici, proprio mentre il Dylan Dog di Tiziano Sclavi parlava di droga. Campagne importanti per aver avuto il coraggio di usare un linguaggio in grado di parlare fantasia, dove la vita è protagonista ma in un modo diretto e dove i messaggi non sono solo prediche ai giovani scapestrati ma racconti fatti per comunicare con loro e non per impartirgli lezioni. Il fumetto si presta a manifestare storie comuni utilizzando sfondi personali e allegorie per esprimere qualcosa intuitivamente comprensibile, accoglie chi legge dandogli modo di entrare in situazioni nuove e di spostare la propria prospettiva durante la lettura, incontrando anche temi importanti su cui altrimenti sarebbe difficile o almeno più difficile parlare. Allora ecco Ranma 1/2 dove lo stesso personaggio è donna e uomo insieme ed è possibile parlare di accettazione del diverso, pensarlo possibile, quotidiano, ecco il toccante e tenero ” Pillole Blu” di Frederik Peeters per parlare di Aids in un modo delicato e magari la sfacciataggine di Ralf Kònig per svelare tematiche omosessuali senza tanti fronzoli ma molta ironia.
Ma qui siamo nel fumetto di autore, cosa c’entra con la psicologia ed il possibile uso per comunicare e capirsi con i ragazzi? Moltissimo. Gli psicologi si stanno avvicinando a questo mondo ricco di possibilità come si è già fatto con quello delle fiabe per i più piccoli, e non solo. Il linguaggio del fumetto permette di riconoscersi e andare oltre i pregiudizi che normalmente si creano tra le generazioni quando si trattano argomenti delicati, come la fragilità, il malessere che si può incontrare nella propria vita di ogni giorno. Nel fumetto è possibile diventare consapevoli anche delle proprie debolezze e trasformare questo in forza per chiedere aiuto al di fuori della storia di nuvole e carta. Il fumetto diventa strumento personalizzato, fruibile con i propri tempi, un modo per capirsi e identificarsi senza i genitori a fianco, uno strumento per vedersi disegnati e uscire dal tratto per diventare realmente più grandi, creando un proprio pensiero sulle cose. Ben utilizzato, il fumetto diventa prevenzione, cultura, attenzione comunicativa.
 Deve averlo capito molto bene il Comune di Milano che con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha realizzato e distribuito 60mila copie di “Uno psicologo tra i banchi” raggiungendo quasi 60 istituti milanesi, testo ragionato dallo psicologo Paolo Campanini e e disegnato da Giuseppe Candita. Storie di ragazzi mezzi su carta, con problemi come tanti, con bisogni e sogni come tanti, che raccontano problematiche importanti, dalla scuola ai problemi di rapporti tra ragazzi, alle relazioni con gli amici o il proprio corpo, alla paura di chiedere aiuto e il trovare il come riuscirci. Una iniziativa che sposta l’attenzione dall’adulto che chiede ai giovani di parlare al ragazzo che si indaga per poi fare lui stesso il passo di poter avere il suo spazio di ascolto. Partendo dalla scuola, mondo dove ogni giorno i ragazzi vivono e scrivono la loro storia, per arrivare direttamente ai ragazzi, per dare a loro le informazioni possibili, in forma congeniale al loro modo di vedere il mondo, perchè siano in grado di chiedere aiuto per le piccole e grandi ferite dell’adolescenza, per i momenti di malessere che ci sono in ogni età ma che in certe hanno ancor più bisogno di ascolto. Perchè l’adolescenza è un momento lungo e carico di emozini e fatica ma allo stesso tempo si tratta di una fase della crescita dove è possibile agire insieme per prevenire problemi peggiori in un momento successivo della vita. Dice, nell’articolo del Corriere, Mauro Grimoldi presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia: “La scuola non è più solo il luogo dove si impara ma anche dove si vive e si cresce. Basta poco per intervenire su piccole “ferite”, mentre aspettando domani si potrebbe scoprire che non è più possibile e che il problema è sfuggito di mano”.
Deve averlo capito molto bene il Comune di Milano che con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha realizzato e distribuito 60mila copie di “Uno psicologo tra i banchi” raggiungendo quasi 60 istituti milanesi, testo ragionato dallo psicologo Paolo Campanini e e disegnato da Giuseppe Candita. Storie di ragazzi mezzi su carta, con problemi come tanti, con bisogni e sogni come tanti, che raccontano problematiche importanti, dalla scuola ai problemi di rapporti tra ragazzi, alle relazioni con gli amici o il proprio corpo, alla paura di chiedere aiuto e il trovare il come riuscirci. Una iniziativa che sposta l’attenzione dall’adulto che chiede ai giovani di parlare al ragazzo che si indaga per poi fare lui stesso il passo di poter avere il suo spazio di ascolto. Partendo dalla scuola, mondo dove ogni giorno i ragazzi vivono e scrivono la loro storia, per arrivare direttamente ai ragazzi, per dare a loro le informazioni possibili, in forma congeniale al loro modo di vedere il mondo, perchè siano in grado di chiedere aiuto per le piccole e grandi ferite dell’adolescenza, per i momenti di malessere che ci sono in ogni età ma che in certe hanno ancor più bisogno di ascolto. Perchè l’adolescenza è un momento lungo e carico di emozini e fatica ma allo stesso tempo si tratta di una fase della crescita dove è possibile agire insieme per prevenire problemi peggiori in un momento successivo della vita. Dice, nell’articolo del Corriere, Mauro Grimoldi presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia: “La scuola non è più solo il luogo dove si impara ma anche dove si vive e si cresce. Basta poco per intervenire su piccole “ferite”, mentre aspettando domani si potrebbe scoprire che non è più possibile e che il problema è sfuggito di mano”.
Una iniziativa questa dello Psicologo tra i banchi che fa sentire fortissima una assenza, quella appunto dello psicologo reale nelle scuole. Purtroppo in Italia questa presenza è vista come accessoria e non indispensabile, lasciata a qualche iniziativa, a titolo gratuito, per lo più, delle diverse scuole, non organizzata e pensata di concerto tra Scuole e Professionisti, non regolata da leggi regionali ad hoc,. E invece il bisogno c’è e la presenza di una tale figura, riconosciuta, capace di fare rete tra scuola e famiglie, di ascoltare e dare spazi immediati e facili nella fruizione ai ragazzi sarebbe senza alcun dubbio, una conquista di civiltà e cultura nell’ottica della prevenzione e dell’Ascolto. Il disagio che corre tra i banchi è notevole e sfaccettato, dal bullismo, agli interrogativi su relazioni e sesso, sulla propria identità, sulle proprie fragilità eppure per molti resta difficile accedere ai Servizi preposti, chiedere aiuto è un passo complesso che spesso sono i genitori a richiedere. Comunicare attraverso questo fumetto chiaramente non colmerà la mancanza, sebbene a Milano sono in molti gli istituti dove lo psicologo c’è e i risultati e l’affluenza parlano da soli di quanto sia uno spazio utile e necessario. Specialmente in una prospettiva futura, di giovani che diventeranno uomini e donne e avranno famiglie a loro volta, investire nel loro ascolto e nel loro benessere non è altro che prevenire problemi peggiori in futuro e limitare le spese di cura che pesano nelle casse del paese, ma purtroppo se da una parte i grandi accusano i giovani di non sapersi creare il domani, viviamo in un paese troppo spesso legato al momento e incapace di progettare a lungo termine. Ma intanto i ragazzi milanesi possono godere di questa buona iniziativa e per una volta un’Ordine sembra davvero promuovere una figura professionale come lo psicologo e provare a costruire una cultura del benessere, partendo da un disegno e da una nuvola di carta.
Pollicino: Studenti alle prese con la loro fantasticamente terribile adolescenza L’Orco : Mancanza di ascolto
L’arma segreta : Il fumetto come strumento per comunicare e raccontare lo psicologo e come chiedere aiuto